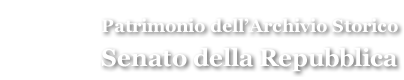unità 234 Marconi Guglielmo, Scalini Enrico, Gavazzi Lodovico, Leonardi Cattolica Pasquale ed altri (Processo Banca italiana di sconto) (1922 - 1926)
Consultabilità
consultabile
Note
Decisione n. 251, 255, 275
Antroponimi
Marconi, Guglielmo Leonardi Cattolica, Pasquale Gavazzi, Lodovico Scalini, Enrico
Segnatura archivistica
ASSR, Ufficio dell'Alta corte di giustizia e degli studi legislativi, 1.2.234
Ufficio dell'Alta corte di giustizia e degli studi legislativi
1866 - 1948
buste 500 circa, 9 volumi, 14 registri, 1 rubrica
Consultabile presso la Sala studio dell'Archivio storico. Strumenti di ricerca parziali.
Il fascicolo processuale intestato a Emilio De Bono è stato descritto analiticamente ed è consultabile online, con la documentazione scansionata e associata. Per l'accesso diretto clicca qui
Digitalizzazione della documentazione a cura dei militari del Nucleo speciale commissioni parlamentari d'inchiesta della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri assegnati all'Archivio storico.